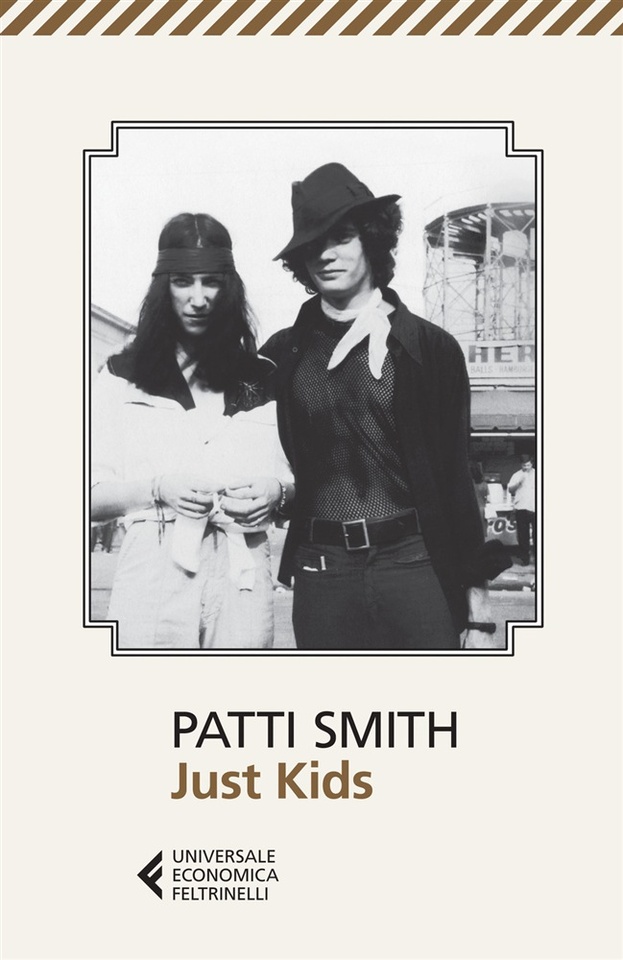ogni motivo è buono per mollare, per uscire dalla clausura. Esci con la scusa di una cartuccia d’inchiostro per la stampante e ti perdi a zonzo. E questo bighellonare certe volte ti premia, fai l’incontro giusto, qualcuno o qualcosa che ti porterai dietro. E così è stato anche stavolta. Sono uscita e ho incontrato un tipo che incontro spesso nel mio quartiere, un barbone con cui ho una certa confidenza, uno che viaggia a vino e cipolle accanto a un canetto sfibrato tenuto da uno spago. Ci vuole cautela, ce l’ha con le donne. Certi giorni è uno zucchero, certi altri esci dal supermercato con un po’ di spesa anche per lui e ti ringrazia con un insulto sessuale che ci resti di sale.
Cercavo una buona idea per Sergio Castellitto, per il suo talento d’attore ma non solo, qualcosa che desse voce alla sua parte muta. Dopo tanti film gli era venuta nostalgia del teatro, della vecchia placenta dove era nato come attore, di quel corpo a corpo con se stesso in quella bolla di polvere e luce. Pensavo a un monologo intimo eppure circense che gli desse la possibilità di sgangherarsi. Perché ogni tanto viene voglia di stendesi sul guanciale dell’abbandono, di dire: ma sì, voglio essere molle e cagionevole, stupido e disdicevole. Voglio sputtanarmi, non ce la faccio più a tenere il punto fermo, la bussola orientata sulla rotta della decenza. Gli attori hanno questa possibilità di sbracare, di prendersi una vacanza dalla normalità. E di essere ben pagati e applauditi per questo. Hai la possibilità di vergognarti senza che nessuno se ne accorga. Di piangerti qualcosa di solo tuo in mezzo a un cumulo di bugie.
Così ho pensato: scrivo di uno che sta in strada, senza sociologia, solo un’anima che vaga, che strepita. Uno di quei sbrancati attraversatori di città. Uno buffo, con le sue miserie, le sue lacrime ma anche una sua strafottenza, un suo umorismo. Uno che non si scansa, che ha accettato il suo destino come la cacata di un uccello sulla testa, imprecando e ringraziando insieme.
Scrivere di un senzatetto è affidarsi alla scabrosità di una possibilità che ti appartiene. Perché gli artisti, spesso e volentieri, sono barboni fortunati. Ce l’hanno fatta a non finire all’addiaccio, ma conservano i tratti disturbati e l’inquietudine dell’erranza, vagano con gli occhi, sentenziano sul mondo, hanno ossessioni, riti. Ogni giorno corrono il rischio di perdersi, di non trovare più la strada del ritorno.
Non ho scelto uno che guarda in terra. Ho scelto uno che avesse ancora voglia di guardare in faccia la gente. Un anatraccio curioso che risale il fiume e scruta i regolari, i “Cormorani”, quelli che stanno nel recinto della società organizzata. Straparla, dice la sua, buon senso e bestialità, ride di gusto e poi s’accascia. Ha un vecchio trauma stretto nel cuore come un trofeo, e un guinzaglio al posto della cravatta: è roba del suo cane, del suo lutto. E’ il cazzotto, la sciancata. E’ il piano della vita che s’inclina, si mette di traverso. Una notte è uscito, s’è messo a quattro zampe, è andato. E’ lurido, come tutti i barboni. Indossa un vestito color birra d’un tessuto che luccica, preso a un centro di raccolta e che magari è il vestito di un morto. Due mollette da panni gli stringono i pantaloni al polpaccio. Scarpe con le suole lisce come dorsi di canoa, scarpe che scivolano sui marciapiedi, sulla melma del lungo fiume, sulle verdure rimaste in terra dei mercati che smontano. La maglietta produce fiammelle, è acrilica, azzurra nazionale, con un bello scudetto dell’Italia. E’ l’allegria che copre il petto, il ghigno che lo gonfia, che sfotte il cielo. Si chiama Zorro, questo ragazzo di mezza età. Zorro come lo spadaccino nero, Zorro come un cane color piscio. E’ incazzato, naturalmente è molto incazzato, oppure ci fa. Non ha più le tessere di accesso, è come quei guidatori spericolati a cui hanno ritirato la patente. Beve, chi sta in strada beve. Dorme in stazione, accanto allo sfiato caldo della metropolitana, sniffa gli odori, guarda le scarpe che passano, guarda le donne. Gliene piace una alla portata, una con il culo basso come il mariciapiede.
Mi sono divertita a farlo parlare, perché scrivere per il teatro è una vacanza, e mi sono commossa perché scrivere di quest’uomo sfortunato mi ha commosso. Ho sempre pensato che la marginalità, nella sua terribile durezza, sia un osservatorio privilegiato. Così queste persone che se ne vanno per i fatti propri borbottando, imprecando, con un vespaio di strani pensieri in testa, mi sembrano il sale della terra, un buon motivo per restare, per festeggiare la vita. Ti guardano da una lontananza mai troppo benigna, minacciosi a volte, esigono il rispetto di chi si è appartato. Stanno sul margine del grande fiume, intenti come pescatori in attesa. Pescano nel nostro vortice quello che rimane, quello che schizza via, che gli appartiene per diritto. Hanno quegli odori concentrati, essenza d’uomo, come mosto, come seccume marino, roba sfinita dal sole o macerata dall’umido, roba che fa il suo corso.
Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che da qualche parte appartiene a tutti. Perché dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c’è questa estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare.
Chi di noi in una notte di strozzatura d’anima, bavero alzato sotto un portico, non ha sentito verso quel corpo, quel sacco di fagotti con un uomo dentro, una possibilità di stesso? I barboni sono randagi scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che non hanno, ma anche di tutto ciò che ci manca. Perché forse ci manca quell’andare silenzioso totalmente libero, quel deambulare perplesso, magari losco, eppure così naturale, così necessario, quel fottersene del tempo meteorologico e di quello irreversibile dell’orologio. Chi di noi non ha sentito il desiderio di accasciarsi per strada, come marionetta, gambe larghe sull’asfalto, testa reclinata sul guanciale di un muro? E lasciare al fiume il suo grande, impegnativo corso. Venirne fuori, venirne in pace. Tacito brandello di carne umana sul selciato dell’umanità.
Perché i barboni sono come certi cani, ti guardano e vedi la tua faccia che ti sta guardando, non quella che hai addosso, magari quella che avevi da bambino, quella che hai certe volte che sei scemo e triste. Quella faccia affamata e sparuta che avresti potuto avere se il tuo spicchio di mondo non ti avesse accolto. Perché in ogni vita ce n’è almeno un’altra.

Margaret Mazzantini, Zorro. Un eremita sul marciapiede, Mondadori 2004
Read Full Post »