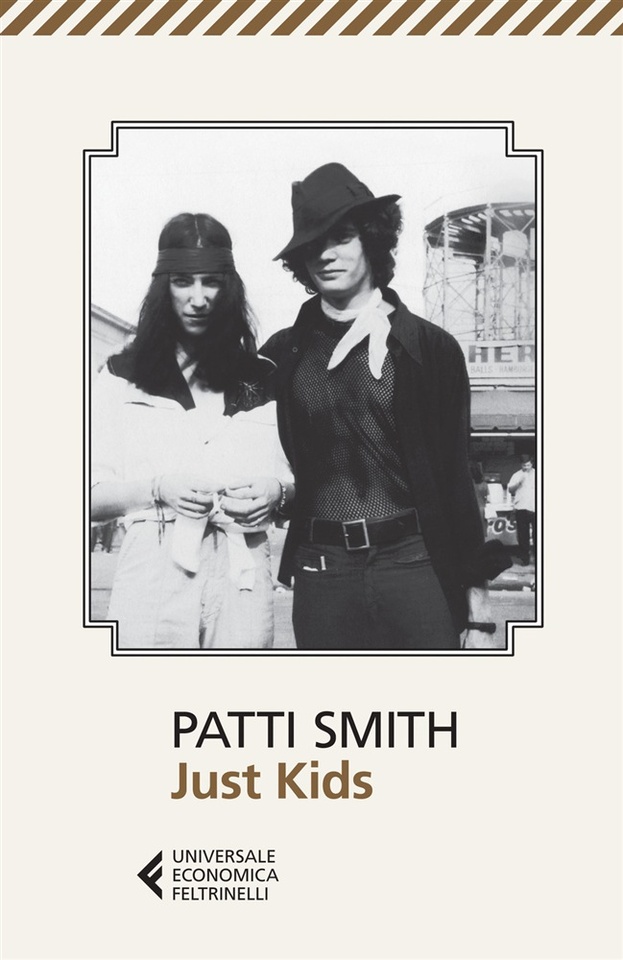Archive for marzo 2018
Turn it down you say
Posted in 1984, I Wanna Rock, Musica, Ricordi, Stay Hungry, Twisted Sister, tagged Musica on 30 marzo 2018| Leave a Comment »
WEEKLY HORROR – Still thinking about food? – L’OCCHIO DEL MALE – Tom Holland
Posted in Cinema, Horror & Co., L'occhio del male, Recensioni, S. King, T. Holland, Thinner, Trasposizioni, Weekly Horror, tagged Cinema, Recensioni, Weekly Horror on 29 marzo 2018| Leave a Comment »

William Hallek è un avvocato obeso dalla morale non eccessivamente rigida. Il pensiero costante del cibo contrasta con la dieta che cerca di seguire senza eccessivi risultati. Una sera, rientrando in macchina da un party, sua moglie lo distrae, per così dire, dalla guida e William non si accorge di un’anziana zingara che sta attraversando la strada.
Investita, la donna muore.
Segue il processo ma non una condanna.
Ad aspettare fuori dal tribunale però c’è il padre della zingara che si avvicina a Will, lo sfiora e sussurra una parola.
Will, di colpo comincia a perdere peso. Dapprima è felice della cosa ma presto si accorge che non c’è niente di naturale nel suo dimagrimento.
Lo zingaro gli ha detto di consumarsi e lui non può fare altro che osservare il lento deperire del suo corpo.
Solo, senza nessuno che gli creda, Will deve trovare il modo di farsi togliere questa maledizione.
1996, titolo originale Thinner, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King uscito nel 1984 ancora sotto lo pseudonimo di Richard Bachman – e che non ho letto, non potendo quindi dire niente sulla fedeltà al testo.
Per la regia di Tom Holland – il papà di Chucky, per intenderci – L’occhio del male è il classico film per la tv tratto da King e da lui stesso sceneggiato.
Il taglio marcatamente televisivo e una certa prevedibilità di trama ne fanno un prodotto decisamente di serie B, ma non per questo necessariamente negativo.
Nonostante i limiti stilistici la trama coinvolge e si è (anche un po’ morbosamente) curiosi di vedere cosa succederà a Will mentre continua a dimagrire a vista d’occhio pur abbuffandosi in modo patologicamente smodato, preda di una fame ormai totalmente fuori controllo.
Incarnazione estrema dell’insano desiderio di mangiare senza freni e, non solo non ingrassare, ma anche dimagrire, Will sprofonda gradualmente in un incubo che sembra non avere via d’uscita.
Cast tutto sommato neanche troppo anonimo, con Robert John Burke nel ruolo di Will, Joe Mantegna e Micheal Constantine.
Non manca neanche il consueto cameo di King stesso, questa volta nei panni di un farmacista.
Imdb.





…you used to be one thing. Now, you’re something else. – Venom
Posted in Cinema, Fumetti, Marvel, Segnalazioni, T. Hardy, Trailer, Trasposizioni, Venom, tagged Cinema, Segnalazioni on 28 marzo 2018| 3 Comments »
Sempre dall’universo Marvel, uscita prevista per il 4 ottobre.
Sembra interessante e la scelta di Tom Hardy non mi dispiace. Resta da vedere se riusciranno a mantenere la complessità e l’ambiguità del personaggio.
My next step will be my last… – MINE – Fabio Guaglione, Fabio Resinaro
Posted in A. Hammer, A. Wallis, Cinema, F. Guaglione, F. Resinaro, Mine, Recensioni, tagged Cinema, Recensioni on 27 marzo 2018| Leave a Comment »

Inizialmente scettica verso quella che dal trailer mi sembrava una scopiazzatura dell’idea di fondo di No Man’s Land (Danis Tanovic, 2001) – un uomo bloccato su una mina – seguendo l’onda del momento-Armie-Hammer in seguito a Chiamami col tuo nome, mi sono finalmente decisa a recuperare questo film.
2016, regia di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.
Armie Hammer protagonista e quasi unico personaggio. Annabelle Wallis in sottofondo.
Nell’ambito di un non meglio identificato conflitto in terra afghana, il marine Mike Stevens sta cercando di rientrare alla base a seguito di una missione fallita che ha costretto lui e il suo compagno a modificare i piani originari.
Quando Mike si accorge di essere su un campo minato è ormai troppo tardi. Il suo piede sinistro calpesta inavvertitamente una mina, inchiodandolo così sul posto.
Solo, in mezzo al deserto, senza quasi più scorte e con i soccorsi troppo lontani per sperare in un’estrazione in tempi brevi.
Mike non ha scelta. Può solo aspettare e resistere.
Mine è un film costruito con pochissimo ma incredibilmente efficace e, decisamente, ho dovuto ricredermi sia sui miei pregiudizi di banalità sia sulla rassomiglianza con No Man’s Land. Quest’ultimo era un film di guerra in senso stretto. Mine è un film ambientato in un contesto di guerra ma che, in definitiva, è tutt’altro.
O meglio. Sempre di conflitti si parla ma non conflitti armati.
Perché la vera guerra che Mike combatte è quella contro se stesso e i suoi fantasmi.
Inchiodati alla poltrona per l’intera durata del film esattamente come Mike è inchiodato al suolo sabbioso, soffriamo con lui, patendo caldo, sete, fame, ma, più di ogni altra cosa, ci troviamo sopraffatti dalla soverchiante sensazione di paralisi di cui la mina è solo un’esternazione superficiale.
Mine – plurale di mina in italiano, sostantivo per bomba in inglese ma anche pronome possessivo in inglese, mio – è un film fortemente simbolico e dalla grande carica emotiva. Le immagini potenti dell’immobilità forzata di Mike ma, soprattutto, delle forze che lo tengono bloccato, costituiscono il percorso della sua liberazione dall’eredità di un passato ingombrante con cui Mike non si è mai deciso a chiudere i conti.
Solitudine e confronto con il proprio io spogliato di tutto. L’idea di poter essere i peggiori nemici di se stessi.
Armie Hammer è decisamente molto bravo e, al di là della presenza scenica particolarmente adatta, regge perfettamente quasi due ore di telecamera piantata addosso, senza strafare e senza lasciarsi scoraggiare dalle scarsissime possibilità offerte dalla staticità del ruolo.
Un film intelligente, che non cade nelle trappole dei cliché troppo facili offerti dalla tematica ma che sfrutta appieno le potenzialità di significato offerte dalla situazione di partenza.




Le storie d’amore catastrofiche contraddistinte da ossessione sessuale sono un mio interesse professionale ormai da molti anni. – FOLLIA – Patrick McGrath
Posted in 1996, Follia, Libri, P. McGrath, Recensioni, tagged Libri, Recensioni on 26 marzo 2018| Leave a Comment »

Si tratta di relazioni la cui durata e la cui intensità differiscono sensibilmente, ma che tendono ad attraversare fasi molto simili: riconoscimento, identificazione, organizzazione, struttura, complicazione, e così via. La storia di Stella Raphael è una delle più tristi che io conosca.
Siamo in Inghilterra, nel 1959 e quella di Stella Raphael è la storia che ci viene narrata dalla voce di Peter Cleave, prima suo amico, poi suo psichiatra.
E’ una storia che nasce all’interno del microcosmo di un manicomio criminale di cui Max Raphael, marito di Stella, è il nuovo vicedirettore.
E’ la storia della passione morbosa e ossessiva tra Stella e uno dei pazienti della struttura, Edgar Stark, rinchiuso per il brutale assassinio della moglie. E per quello che ha fatto dopo al suo cadavere.
Stella e Edgar. Una coppia talmente improbabile da risultare impensabile. Una relazione che nasce subito come ossessione e che si impossessa di Stella azzerando di colpo qualsiasi difesa, annullando in brevissimo tempo qualsiasi pretesa di volontà. Una passione fortemente sessuale e altrettanto fortemente compensatoria per tutto ciò che è opposto alla vita che Stella ha sempre condotto.
Ma non è sufficiente. Perché quello di Stella non è un mero atto di trasgressione e quella di Edgar non è solo una cinica manovra per raggiungere i suoi scopi.
Un viaggio allucinato negli abissi di una psicosi sempre più profonda e sempre più totalizzante. Una storia sordida, spiata attraverso lo spiraglio (auto)giustificatorio dell’analisi psichiatrica. Una storia morbosa dalla quale risulta impossibile staccarsi.
Sono diversi mesi che Patrick McGrath staziona nella mia coda di lettura. A ottobre, se non mi sbaglio, è venuto a Torino al Circolo dei Lettori per presentare il suo ultimo libro, La Guardarobiera, ma alla fine non ero riuscita ad andare. Da allora però mi sono incuriosita per questo scrittore cresciuto nell’ambiente del manicomio criminale presso cui suo padre lavorava come psichiatra e mi sono ripromessa di leggere qualcosa. Per un po’ sono stata indecisa se incominciare L’estranea ma alla fine ho deciso di iniziare con questo Follia, che è il suo titolo più famoso e che si è rivelato assolutamente all’altezza della sua fama.
La scrittura di McGrath è ipnotica e impossibile da lasciare. Ti tiene incollato alle pagine, ti risucchia in un vortice di orrore a attrazione dal quale è impossibile staccarsi.
Un gioco di specchi in cui il confine tra normalità e follia si fa sempre più labile e un cui i ruoli si confondono e si capovolgono fino a sradicare qualsiasi certezza.
Davvero bellissimo. Una folgorazione. Siamo solo a marzo e le graduatorie sono un po’ premature ma, per il momento, va dritto in cima alla mia classifica del 2018.
Patrick McGrath, Follia, Adelphi Edizioni, 1998
I’m not sure all these people understand
Posted in 1992, Automatic for the People, Musica, Nightswimming, R.E.M., Ricordi, tagged Musica on 23 marzo 2018| Leave a Comment »
WEEKLY HORROR – She desires of my blood. – THE WITCH – Robert Eggers
Posted in Cinema, Horror & Co., R. Eggers, Recensioni, Weekly Horror, tagged Cinema, Recensioni, Weekly Horror on 22 marzo 2018| 2 Comments »

New England, 1630. Un colono e la sua famiglia vengono scacciati dalla loro comunità presumibilmente per motivi religiosi.
Si allontanano dunque dalle piantagioni e trovano una sistemazione ai margini della foresta dove tentano di sopravvivere coltivando, cacciando e osservando la parola di Dio.
Eppure, fin dall’inizio, le cose non vanno per il verso giusto.
Il più piccolo dei figli scompare inspiegabilmente e questo evento dà il via ad una serie di disgrazie sempre più terribili.
C’è qualcosa di maligno che ha preso di mira la famiglia, e il maligno si può nascondere ovunque. E in chiunque.
Per la regia dell’esordiente Robert Eggers, The Witch è un film decisamente insolito e anche piuttosto inaspettato.
Basato in parte su racconti e testi originali del 1.600 – alcuni dialoghi sono addirittura trasposizioni letterali prese dai registri e dai documenti riguardanti i processi per stregoneria – questo film, presentato per la prima volta al Sundance nel 2015, ha fin da subito suscitato grande interesse e riscosso notevole successo.
Quattro anni di produzione, ventisei giorni di riprese, girato, a quanto pare, nello stesso formato ideato da Kubrick per Barry Lyndon (1.44:1) e totalmente in luce naturale per gli esterni e a lume di candela per gli interni, un budget di tre milioni e mezzo di dollari per un incasso quasi immediato di 40 milioni.
Una ricostruzione storica meticolosa in ogni minimo dettaglio – dalla quotidianità delle attività contadine ai modi di esprimersi e di relazionarsi – fa da sfondo ad una vicenda che mescola in modo inquietantemente plausibile reale e sovrannaturale.
Il passaggio dalla fede al delirio religioso è graduale ma inesorabile. La caccia alle streghe può avvenire ovunque e nessuno è immune se può fungere da giustificazione per le avversità.
Se la sensazione di minaccia incombe fin dall’inizio, man mano che si procede l’atmosfera intorno alla famiglia diventa veramente insostenibile nel farsi sempre più cupa e opprimente.
Storia di streghe del bosco, fiaba per non dormire ma anche critica rappresentazione simbolica socio-politico-antropologica di una realtà dove i veri demoni tramano indisturbati all’ombra di un patriarcato prevaricante e negli angoli bui della cattiva coscienza di una religione e di una società fortemente discriminanti e intolleranti.
Angosciantissimo nella sensazione di impotenza che trasmette, insieme ad un senso di oppressione che si fa via via intollerabile fino a diventare delirio allucinato.
Un film intelligente e realmente diverso da tutto quello che c’è in circolazione di più o meno rientrante nel genere – quanto meno parlando del panorama degli ultimi 10-15 anni.
Buono il cast, seppur privo di nomi celebri, con particolare menzione per Anya Taylor-Joy – qui al suo esordio cinematografico – nel ruolo di Thomasin.
Decisamente consigliato.






C’è stata un’esplosione. Si allontani. – OLTRE LA NOTTE – Fatih Akin
Posted in 2017, 2018, Aus dem Nichts, Cannes, Cinema, D. Kruger, F. Akin, Golden Globe, Recensioni, tagged Cinema, Globes, Recensioni on 21 marzo 2018| Leave a Comment »

Miglior attrice Diane Kruger a Cannes 2017.
Golden Globe 2018 come miglior film straniero.
Regia di Fatih Akin – La sposa turca (2003), Soul Kitchen (2009), tra gli altri.
Germania. Katja, tedesca, Nuri, curdo.
Marito e moglie. E Rocco, il loro bambino.
Una famiglia mista, come tante. La quotidianità, il lavoro, le bollette da pagare, gli sbagli da superare e da lasciarsi alle spalle.
Finché, all’improvviso, tutto crolla.
Una bomba piazzata davanti all’ufficio di Nuri uccide lui e Rocco e Katja si trova precipitata nelle profondità di un inferno senza via d’uscita.
L’attentato si rivela ben presto di stampo neonazista e Katja deve affrontare un processo che apre uno squarcio impietoso sulla realtà dell’insensatezza della morte dei sui cari.
L’orrore idiota delle tensioni razziali e delle intolleranze sempre più frequenti in Germania. L’inadeguatezza di leggi e persone.
Diane Kruger è davvero immensa in un ruolo che non è mai patetico ma è tanto intenso da spezzare il cuore.
Un film bellissimo e terribile. Uno di quei film difficili da vedere ma necessari.
Non c’è posto per cliché o vuoti sentimentalismi.
C’è solo l’imbecille verità di un male ingiustificabile e del vuoto che si lascia dietro.
C’è la realtà concreta di un mondo che non sembra in grado di affrontarlo, questo male, come un genitore attonito di fronte a un figlio sfuggito al controllo e macchiatosi di colpe abominevoli.
Una regia asciutta, essenziale. La telecamera quasi sempre addosso a Katja e alla sua straziante solitudine.
Una condanna senza possibilità di appello.
Assolutamente imperdibile.




Cominciò senza un inizio. – SYLVIA – Leonard Michaels
Posted in L. Michaels, Le parole degli altri, Libri, Recensioni, Sylvia, tagged Libri, Recensioni on 20 marzo 2018| Leave a Comment »

All’improvviso Sylvia smise di spazzolarsi, andò nel soggiorno, si lasciò cadere sul divano, si appoggiò con la schiena alla parete di mattoni e si abbandonò completamente. Poi, da dietro la lunga frangia nera, i suoi occhi si mossero, mi guardarono. Il dubbio su cosa fare della mia vita fu risolto per i quattro anni successivi.
I primi anni Sessanta. MacDougal Street, nel cuore del Greenwich Village. Il fervore visionario, poetico, rivoluzionario di quegli anni. L’aria pesante di erba e di idee di musica. Appartamenti scalcagnati, divani sfondati, corridoi male illuminati. Vita universitaria, locali fumosi, discussioni interminabili, una macchina da scrivere scassata e racconti che non vogliono prendere forma.
Sono solo alcune delle immagini che rimangono impresse riemergendo dal turbine vorticoso che è questo piccolo romanzo di Leonard Michaels.
Il memoir romanzato del suo primo matrimonio con una ragazza bellissima e folle. Ma non di quella follia che andava per la maggiore nel fermento culturale dell’epoca. Non la follia creativa di artisti di strada e poeti ubriachi.
Quella in cui Sylvia sprofonda – trascinando con sé anche Leonard – è la follia (auto)distruttiva della psicosi. Di una rabbia incontrollabile e incontrollata. Di un odio per se stessa e per il mondo intero. Una rabbia che brucia e brucia e brucia fino a divorare ogni cosa.
La relazione tra i due nasce quasi per caso ma si connota da subito come un legame imperativo. Di quelli che nessuno si spiega, tanto meno gli interessati. Di quelli che si mangiano ogni cosa e che forse nella vita non si incontrano mai.
E il mondo di Leonard diventa Sylvia.
Sylvia e le urla furiose che vanno avanti per ore.
Sylvia e gli oggetti spaccati contro i muri.
Sylvia e i gesti sempre sbagliati.
Sylvia e le accuse, le colpe, le condanne.
Sylvia magra, nel suo cappotto di cuoio troppo leggero, zoppicante con un sandalo rotto, sofferente per dolori forse immaginari.
Sylvia solo vagamente consapevole di ciò che accade intorno.
Le parole di Michaels ricostruiscono i tratti di una vicenda che, raccontata, ha del surreale ma riesce anche a rendere bene l’idea di come la psicosi e l’assurdo si insinuino lenti e subdoli nel quotidiano, ospiti quasi invisibili ma inevitabilmente letali. Artefici di un allucinato inferno di coppia che soffoca e annulla il mondo circostante.
Un libro sull’ossessione e sulle profondità della mente e dei legami, che ti tiene incollato dall’inizio alla fine in una descensio che non lascia scampo.
Una corsa inarrestabile verso il precipizio e un esito prevedibile eppure sconvolgente.
Un libro bellissimo e terribile, di una verità disarmante e quasi insostenibile.
Non c’è salvezza, non c’è redenzione per Sylvia, che rivive in queste pagine come un ultimo urlo, come un ultimo sguardo da sotto la frangia di capelli neri.
Sarebbe stato facile lasciare Sylvia. Fosse stato difficile, forse l’avrei fatto.
Leonard Michaels, Sylvia, Adelphi, 2016
All myths are foundations of reality. – TOMB RAIDER – Roar Uthaug
Posted in 2018, A. Vikander, Cinema, D. West, K. Scott Thomas, Libri, R. Uthaug, Recensioni, Tomb Raider, Tomb Raider The Art of Survival, Trasposizioni, Videogiochi, W. Goggins, tagged Cinema, Recensioni on 19 marzo 2018| 2 Comments »

Quando l’anno scorso ho visto il primo trailer di questo nuovo Tomb Raider ho ovviamente accolto la novità con la mia consueta buona disposizione d’animo verso i reboot, cioè bestemmiando forte perché porcaputtana l’unica vera e inimitabile Lara Croft rimane Angelina. Punto. E Alicia Vikander mi piace tanto ma con Lara non c’entra un tubo e blablabla via così.
Detto ciò, come al solito brontolo e bofonchio ma poi i film li vado a vedere lo stesso. E meno male.
Perché questo nuovo Tomb Raider ha molta più ragione d’essere di molti reboot in circolazione ed è innegabilmente coerente con la fonte da cui deriva in quanto è tratto da Tomb Raider del 2013, primo capitolo della terza serie di videogiochi di TR ed esso stesso reboot della saga originale (uscito per PS3, Xbox360 e PC).
 Reboot per il quale era stato fatto un consistente lavoro di restyling e riammodernamento, per così dire, della figura di Lara. Una Lara che, in effetti, in questa versione, della Jolie ha ben poco, sia in termini di tette fisico che di carisma.
Reboot per il quale era stato fatto un consistente lavoro di restyling e riammodernamento, per così dire, della figura di Lara. Una Lara che, in effetti, in questa versione, della Jolie ha ben poco, sia in termini di tette fisico che di carisma.

Non più la Lara supercazzuta, ricca e affermata della prima serie – e quindi dei film del 2001-2003. Non la Lara che spacca il culo a tutti, super sicura di sé e già esperta, ma una ragazzina alle prese con l’eredità del padre e con la sua misteriosa scomparsa.
Non che questa nuova Lara non sia carismatica, ma è un tipo di personaggio parecchio diverso pur senza stravolgere del tutto l’iconografia tradizionale che la contraddistingue e che l’ha resa un mito.
E’ una Lara per certi versi molto più umana.
Poi gli elementi tipici ci sono tutti lo stesso – le armi, le tecniche, gli espedienti di gioco e di azione. Solo, ci si arriva diversamente.
Parentesi, per chi fosse interessato, oltre al videogioco, c’è anche questo libro qui, che spiega in dettaglio il progetto alla base del reboot, sia in termini di realizzazione tecnica che di ridefinizione del personaggio. Fighissimo. Chiusa parentesi.
che spiega in dettaglio il progetto alla base del reboot, sia in termini di realizzazione tecnica che di ridefinizione del personaggio. Fighissimo. Chiusa parentesi.
Il film di Roar Uthaug è una trasposizione coerente con lo spirito di questo lavoro e porta sullo schermo la storia della nuova Lara in modo incredibilmente fedele, sia per quel che riguarda gli aspetti visivi – attrezzature, ambientazioni, movimenti (ogni volta che Alicia rimaneva attaccata ad una sporgenza con una sola mano mi veniva istintivamente da schiacciare il quadratino del controller della PS per non farla cadere) – sia per la trama che, pur con le dovute modifiche per farne un film, presenta tantissimi punti in comune sia con TR 2013 sia con il successivo capitolo Rise of The Tomb Raider – uscito nel 2014 e che al momento sto giocando su PS4 – mentre le trame dei due primi film non riprendevano direttamente le storie dei videogiochi ma ne sviluppavano di analoghe ma indipendenti – e se aggiungo ancora un trattino o una parentesi potete abbattermi.
Per chi conosce i videogiochi c’è sicuramente una parte di divertimento in più perché è veramente un grande cosplay super curato in ogni particolare – la scena dell’aereo arrugginito è fighissima e il livello di dettaglio è davvero maniacale, ciondolo di Lara compreso.
Per chi veda il film senza altri riferimenti, penso che sia comunque un film d’azione divertente pur senza eccessive pretese in termini di complessità.
Nel cast anche Dominic West, Kristin Scott Thomas e Walton Goggins (Venus dei Sons of Anarchy).