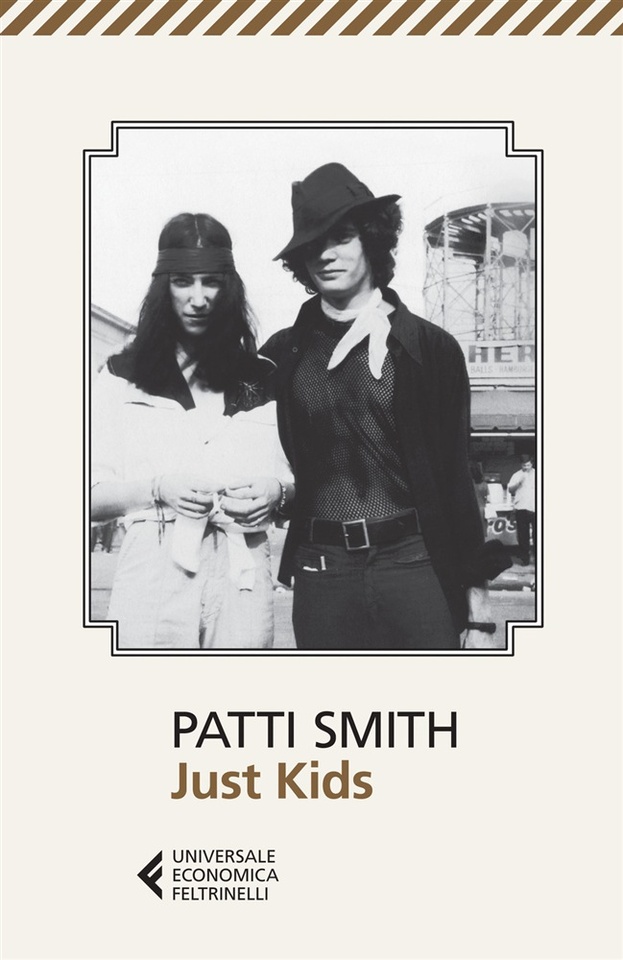*La proprietaria del blog ha dei seri problemi.
Ne è un chiaro indice il fatto che continui a parlare di sé in terza persona e che stia tentando da un’ora di iniziare il post senza riuscire a scrivere due righe.
Altro segnale rivelatore potrebbe essere la comprovata incapacità di staccarsi da YouTube e dai video dell’altra sera.*
Non avevo mai sentito i Placebo live.
Li seguo praticamente da sempre ma, per un motivo o per l’altro, non ero mai riuscita ad andare ad un loro concerto.
Il che, se si considera il periodo deeply-addicted&obsessed in cui sono risprofondata negli ultimi due-tre anni, amplifica notevolmente le proporzioni dell’evento dell’altra sera, conferendogli i tratti di un avvenimento epocale.
Biglietto comprato a maggio.
Albergo prenotato a giugno.
Treni prenotati a ottobre.
Un improvviso interesse per le condizioni sindacali dei dipendenti FS, chè se per caso saltava fuori uno sciopero il 22 era pronta un’attrezzatura per spedizioni polari per raggiungere la meta eventualmente anche a piedi.
Preparativi sparsi in tutti i mesi di attesa.
Un improvviso interesse per il meteo dell’Emilia Romagna – nonostante la radicata avversione per il concetto di previsioni meteo.
Il merchandise ordinato sul Placebo-store – perché bisogna pur far qualcosa per mitigare l’ansia.
Lo striscione sparpagliato tra Milano e Pisa e ricongiunto all’ultimo.
Il raptus dei cartelli da preparare nell’ultima settimana.
E la pioggia che qui a Torino ha fatto anche finta di diventare neve per un po’, giusto per aggiungere un po’ di pathos alla faccenda.
Torino-Monza-Milano-Bologna-Casalecchio di Reno.
Siamo in tre.
Sono le 11 del mattino e, nonostante il miei tentativi di negare l’evidenza mascherati da ottimismo, sta piovendo e tira pure un vento gelido.
Davanti all’Unipol ci siamo noi e qualche altro esemplare di fan che si aggira sperduto intorno agli ingressi, probabilmente chiedendosi se sia effettivamente il caso.
Pare ci sia qualcuno che ha dormito in macchina lì davanti.
Il richiamo del cancello senza nessuno davanti è indiscutibilmente forte. Ci si avventura tra le corsie per le code, così, giusto per vedere che effetto fa, ma, tempo di arrivare lì davanti e si sa già che non si mollerà più la posizione neanche in caso di uragano.
Presente il momento in cui i protagonisti si guardano e realizzano di essere fottuti? Ecco, proprio quello lì. Un po’ come Bruce Willis in Armageddon, we say our last goodbyes e cerchiamo una posizione tollerabile, compatibilmente col fatto che non ci si può sedere per terra e il vento cambia direzione all’improvviso – il che crea almeno il diversivo del recupero dell’ombrello fuggitivo.
Ad un certo punto, nel grigio brumoso della ridente zona commerciale che si stende intorno all’Unipol si vede sfrecciare un garrulo esemplare di fan a bordo di un carrello dell’Ikea usato come skateboard. Occhi pallati e truccati in perfetto stile panda Molko anni 2000, il tizio è poi scomparso definitivamente dopo qualche passaggio. E non era neanche ancora l’una.
Gente che comincia cauta ad arrivare.
Strane configurazioni di ombrelli – che tanto avrai sempre un rivolo che ti cola a tradimento su una zona non protetta.


I sacchi di nylon per avvolgere il contenuto della borsa – dopo gli studi Rai di settembre pare stia diventando una specie di tradizione che quando c’è il Molko in circolazione io mi munisca di sacchi di nylon anti-pioggia.
Il centro commerciale che diventa improvvisamente il posto più bello in cui si sia mai messo piede, quando tra l’una e le due ci si alterna a gruppetti per nutririsi e recuperare l’uso degli arti inferiori pur senza mollare il presidio.
I bagarini piazzati davanti alle biglietterie ancora chiuse. Se non fosse che la pioggia ha notevolmente fiaccato la mia indole di paparazzo, li avrei anche immortalati.
La voce di Brian che all’improvviso risuona sotto la pioggia mentre dentro stanno provando Too Many Friends – e a questo punto, se fossi una fan modello, dovrei dilungarmi su come, per effetto della voce di Brian, improvvisamente il freddo e la pioggia siano spariti di colpo ma no, non sono una fan modello e continua a fare un freddo cane.
Tizi dell’Unipol che ogni tanto si aggirano in prossimità dei cancelli e che vengono immancabilmente bersagliati di domande sull’effettivo orario di apertura – che, altrettanto immancabilmente, cambia tutte le volte.
Tristi tentativi di depistaggio da parte di alcuni esemplari di sedicenti fan geneticamente progettati per tentare di neutralizzare la loro stessa specie tramite l’originalissimo espediente del “ma-voi-siete-in-coda-dalla-parte-sbagliata-quella-giusta-è-di-là-(=dietro di loro)” #gentechemeritaunamortedolorosa.
Il pomeriggio passa più in fretta perché c’è l’obiettivo dell’apertura delle biglietterie.
Il biglietto finalmente tra le zampe (ma perché diavolo SeeTickets si ostina a stampare cuori a caso sui biglietti? vabbè) e il momento in cui d’improvviso si realizza che ohccazzo-ma-stiamo-per-vedere-i-Placebooooo!! – ché fino a quel momento mica ti è ancora chiaro il motivo per cui ti stai sottoponendo a tutto ciò.
Chiacchiere, cazzate, qualcuno che canta qualcosa, ma controllano le borse? ma le bottiglie possono entrare? e gli ombrelli? Gente che, nel dubbio, si disfa di qualunque cosa, perché ormai c’è la polizia e ci sono gli Unipol-Men fissi ai cancelli, il che vuol dire che ormai ci siamo.
Aprite insieme i due cancelli del parterre? Sì sì. Cosa che per poco non è andata esattamente così ma fa lo stesso, lo scarto non è stato poi determinante.
Aprono.
Biglietto proteso in avanti.
Borsa aperta praticamente lanciata sotto il naso di un poliziotto.
Hai degli accendini? Non si possono portare gli accendini.
Ma che cazzo di domanda è?
Sì, ho degli accendini, due per l’esattezza e no, non glielo dico. Se veramente spera di riuscire a trovare qualcosa di piccolo nel caos di quella borsa è un ottimista come me per la pioggia. E se vuole davvero controllare sono pronta a regalargli la borsa con tutto il contenuto.
Mi assicuro che non voglia sapere altro e bon, comincio a correre.
Corro. Ché non conta un cazzo se sei stato otto ore attaccato al cancello in primissima fila se poi ti passano tutti davanti (sopra) nel tragitto tra il cancello e il palco.
Corro. Io che ho sempre sostenuto – e sostengo tuttora – con orgoglio di non essere in grado di correre neanche per salvarmi la vita. Io che odio correre e che mi sopporterò mesi di prese per il culo perché solo il Molko poteva riuscire a farmi correre.
Corro e riesco per qualche strana congiunzione astrale a non ammazzarmi giù dalle scale – penso vagamente che sembra di stare in un cazzo di hunger game.
Corro e punto la giacca della socia che si è lanciata in avanti poco prima di me. Non vedo neanche il palco. Vedo dov’è lei e basta, al resto ci penso poi. Sperimento un barlume di spirito agonistico a me sconosciuto quando un tizio mi supera sulla destra ma o corro o ringhio, fiato per fare tutte e due le cose non ce l’ho.
Corro e arrivo. Transenna.
Transenna centrata Stef. Sono morta. Prima volta. Morirò altre svariate volte nel corso della serata.
Alla fine hanno aperto alle 7, il che vuol dire che non c’è poi molto da aspettare. Birra, per prima cosa. Poi. Creazione di una configurazione che permetta possibilmente di togliersi un po’ di strati di dosso ma di mantenere le mani libere, il tutto senza devolvere cellulare, chiavi e macchina fotografica alla causa. Sulle tribune si sta assemblando lo striscione e noi si comincia a distribuire i cartelli con la scritta THANK YOU da tirar su alla fine di Teenage Angst.
Nonostante i miei timori, i fan si dimostrano docili e collaborativi – una volta prese le posizioni si torna incredibilmente ad essere tutti amici – e i cartelli si sparpagliano in fretta.
Palco allestito per gli opener, i Toy.
Passa un Unipol-Man che per qualche motivo dice no, no, non vi alzate ancora. Il che ha come conseguenza inevitabile che tutti si alzano.
Le dinamiche della massa sono affascinanti.
Mi sistemo sulla transenna. Mi ci abbarbico. Familiarizzo con quei centimetri di metallo a cui penso da mesi e che in quel momento sono il posto più bello in cui sia mai stata.
Arrivano i Toy sui quali mi ero brevemente documentata nei mesi scorsi e, davvero, non sono affatto male. Resta da capire quanto abbia inciso nella scelta il fatto che Tom Dougall sembri un piccolo Molko per quel che riguarda trucco, capelli e movenze. Esiste dunque una soglia minima di molkitudine necessaria per essere presi in considerazione come opener? Argomento da approfondire.
Già sull’ultimo pezzo dei Toy io comincio stranamente a scollegarmi.
Qualche ragazza portata via dallo staff, causa malore – senza nulla togliere al Placebo-effect continuo a pensare che il passaggio al caldo e alla folla dopo otto ore di freddo possa aver giocato il suo ruolo.
Io mi spengo per un attimo e il momento dopo mi prende il panico. Non ho la più vaga idea del perché ma il meccanismo è stato un po’ oddio-arrivano-davvero-ho-paura-vado-via.
Suppongo si chiami emotività devastata.
In ogni caso non potrei muovermi neanche volendo perché ormai sono definitivamente incastrata.
Le solite foto al palco vuoto e ai tecnici.
In alto si vede il telo semitrasparente che scenderà davanti a Brian e soci su alcune delle canzoni e che non piace particolarmente a nessuno. L’ennesimo capriccio della diva Molko che polemizza per l’eccessivo paparazzamento da cellulare, ma alla fine va bene lo stesso.
Buio. Parte la base di B3 e io per poco non mi perdo l’entrata perché un enorme tizio dello staff stava tirando via l’ennesima fanciulla accasciata proprio sopra la mia testa.
Steve arriva saltellante come sempre.
Stef si sta sempre più molkizzando perché entra quasi senza salutare come insegna il frontman.
Brian arriva praticamente insieme a lui e questo fa sì che quei pochi neuroni che ero riuscita ancora a mantenere in vita collassino miseramente.
Brian.
Brian che ho visto miliardi di volte su un palco.
Brian che so esattamente come si muove, di cui conosco i dettagli di ogni singolo gesto.
Brian che si tira indietro i capelli col mignolo (che tra l’altro è una cosa scomodissima).
Brian che si fa mettere il microfono ancora più basso del necessario e poi ci si contorce sotto.
Brian che palesemente ha una filosofia tutta sua per quel che riguarda il microfono.
Brian che dopo tre canzoni è già sudato come se avesse corso per tre ore sotto il sole e io che vedo una goccia di sudore che cade dai suoi capelli in una coincidenza degna dei migliori screenshot.
Brian che è veramente preso benissimo e lo si capisce da come scandisce in modo ancora più marcato. Già dall’espressione aristocraticamente infastidita sui dilettants di B3.
Brian che ringrazia in italiano.
Brian che ha un paio di stivali nuovi, marroni, come la cintura, pantaloni, camicia e gilet neri.
Brian che ha cambiato leggermente il testo di B3 anche se non è ancora ben chiaro il motivo.
Brian che urla e la sua voce che è perfetta, pulita, esattamente quella che ho nelle orecchie tutti i santi giorni.

Stef è esattamente davanti a me ed è ormai chiaro ai più che si sta creando un secondo frontman. Dall’epoca Battle in poi Stef è praticamente impossibile da ignorare. Che sia una tecnica concordata per compensare il fatto che Brian gira sempre di meno sul palco? mah. Resta il fatto che la cosa non dispiace.

For What It’s Worth è in effetti un po’ inutile ma d’altronde lo era pure B3, ma questi erano i discorsi prima di essere lì. Adesso questa è la migliore setlist al mondo.
Loud Like Love dal vivo mantiene tutte le sue promesse. E’ fatta per essere urlata, per saltare, per mandare via qualsiasi altra cosa.
Twenty Years, che ormai non la toglieranno più finché non saranno ufficialmente passati i loro vent’anni e che, con l’arrangiamento che hanno messo a punto, è ancora meglio che in originale.
Quando parte l’attacco di Every Me Every You…ecco, lì penso sia la seconda volta che sono morta. Come realizzare di nuovo la realtà di tutto quanto. Qualcosa che ha a che fare con tempi che si mescolano e passato che si comprime per arrivare esattamente qui e adesso. E Brian che arriva dal nostro lato sulla chiusura. E il sorriso.
Too Many Friends e il suo computer pensante che l’abbiamo urlato veramente in dodicimila, nessuno escluso.
Scene Of The Crime e la concentrazione per non sbagliare a battere le mani. Occhi fissi su quelle di Stef, che però ha un ritmo un po’ strano e dopo un po’ mi perdo comunque. Per colpa delle mani di Stef.
A Million Little Pieces sempre dietro il sipario trasparente calato prima su Scene. Non è che non ci si veda attraverso, solo che funziona se si sta esattamente davanti perché a guardare di lato si vede effettivamente maluccio.
Speak In Tongues, seconda superstite di Battle, bella, con quella parte finale in crescendo e il telo che si ritira su proprio prima di don’t let them have their way.
Rob The Bank, che forse non sarà il massimo come testo ma è divertente e dal vivo rende bene. E l’espressione schifata di Brian su pick your nose. E il pezzo studiato apposta per far battere le mani sulla batteria di Steve.
Purify e like a fallen angel che più acuto e più femminile di così non poteva venirgli.
Space Monkey e il telo che cala di nuovo (e a momenti prende in testa uno dello staff). E io che non ci posso credere che l’abbiano di nuovo inserita in setlist dopo tutto il tempo che è passato. Space Monkey che non l’ho ancora capita del tutto adesso, ma che ho sempre amato tantissimo. Space Monkey sulla quale ho urlato veramente come se non ci fosse un domani.
Blind, sempre dietro la tenda. Altra chicca, altro brano meraviglioso che non si sentiva live da un po’. La mania che gli è presa a Brian di alzare i toni alla fine, a differenza che nell’originale. Anche se poi il risultato è ottimo lo stesso.
Exit Wounds, la mia preferita dell’ultimo album. Avevo un po’ di timore perché qualche data fa, non mi ricordo esattamente quando, non era venuta un granché, ma fortunatamente è stata perfetta.
Meds, sempre col solito arrangiamento live, le ondate di pogo e la pausa prima dell’ultimo forget, con gli occhi di Brian che vagano inquisitori sulla folla, come a voler controllare se c’è qualcuno che non urla abbastanza.
Song To Say Goodbye e un arrivederci in italiano infilato alla fine. E Brian in punta di piedi sulla seconda strofa (che poi perché? boh, però ormai lo fa quasi sempre) e la voice that made all of us cry.
Special K, di nuovo dietro il telo. Pogo. Tanto pogo. Ad un certo punto non respiro per un po’ e comincio a fare mentalmente il check di quanti organi vitali sento minacciati in quel momento.
Bitter End e il mondo che viene giù. Intro con Stef che dirige le urla come un direttore d’orchestra dalle movenze sinuose.
Prima uscita. Inchino di Brian.
Rientrano dopo pochissimo.
Teenage Angst, con il nuovo arrangiamento che ci sta decisamente meglio di quello saltellante che si ostinavano a fare fino allo scorso tour. E i cartelli THANK YOU tirati su alla fine. Tanti. Più di quello che mi aspettavo. Brian che ringrazia, Stef che mostra segni di affetto. Non dico che a momenti mi ci metto a piangere perché altrimenti dovrei dire anche di tutte le altre volte.
Running Up That Hill, con lo sguardo in alto che grida screenshot da tutte le parti.
Post Blue, che è la mia, anche se forse non ho ancora capito bene il perché, ma che è la mia e basta. E che molti vorrebbero togliere dalla setlist e dall’encore ma che io spero non tocchino mai.
Infra Red in chiusura come al solito. Brian energico fino alla fine che a un certo punto zompa come ai vecchi tempi. E che si mette ad armeggiare con la pedana sotto il microfono anche se ormai hanno praticamente finito tutti di suonare.
Steve che lancia le bacchette e la tipa di fianco a me che cerca di staccarmi un braccio, anche se siamo palesemente tutte e due fuori traiettoria.
Steve che lancia anche le sue scarpe e se non avesse paura di venire cazziato probabilmente lancerebbe davvero anche la cintura.
Brian che ritorna davanti a noi per ringraziare, con i suoi modi orientali che mi starebbero sul culo in chiunque altro ma tanto con lui mi si azzera qualsiasi capacità di critica.
Fiona che viene avanti, si allinea agli altri per l’inchino finale ma Brian è ancora impegnato a ringraziare, inchinarsi e non si sa bene cos’altro, con il risultato che si crea per un attimo una perfetta sintesi di quello che deve voler dire vivere nei Placebo: tutta la band che aspetta mentre Brian si fa i cazzi suoi.


Arriva. Afferra la mano di Stef (che non è un momento molsdal, lo so, ma se qualcuno ce lo vuole vedere non dispiace in ogni caso, visto che comunque durante tutto il concerto se ne può rintracciare solo un altro e molto vago #lecosecheunopotrebbeanchenondire). Inchini. L’urlo di Brian. Le punte dei suoi stivali che spuntano fuori dal palco.
E i momenti sparsi che mi arrivano come flash, all’improvviso. Brian che a un certo punto si butta all’indietro e rimane così per un attimo.
Fiona che balla su Post Blue.
Stef che si sporge e urla verso di noi.
Stef con il pugno sul cuore, quando ci ringrazia.
Brian che si asciuga il sudore dal viso con un asciugamano, ma senza sfregare, che sennò viene via il trucco.
E il bicchierone del suo solito intruglio salva-voce, che ora ha anche Stef – lo dicevo io che si sta tramutando in un frontman.
Concerto fantastico. Perfetto in ogni dettaglio. L’ovvia considerazione cazzo-ma-sono-proprio-bravi-dal-vivo! che non ha davvero nessun senso farla, ma alla fine viene fuori lo stesso.
La consapevolezza che hanno ancora tanto da dire. E l’onestà con cui riescono a dirlo. Le parole di Brian. Le parole che ti arrivano dritte al centro di qualcosa che avresti voluto esprimere senza trovare il modo. La verità dolorosa, sotto gli atteggiamenti da diva, sotto il trucco, dietro gli occhiali scuri. La verità lucida e senza compromessi.
Grande esperienza, davvero. Ho male dappertutto, sono in piena depressione post-concerto e non penso che nulla avrà mai più senso nella mia vita. Non potevo chiedere di meglio.
Ora non mi resta che monitorare in attesa delle date estive.
[Per le foto di Brian che ringrazia non ho trovato l’autore. Si accettano segnalazioni al riguardo]