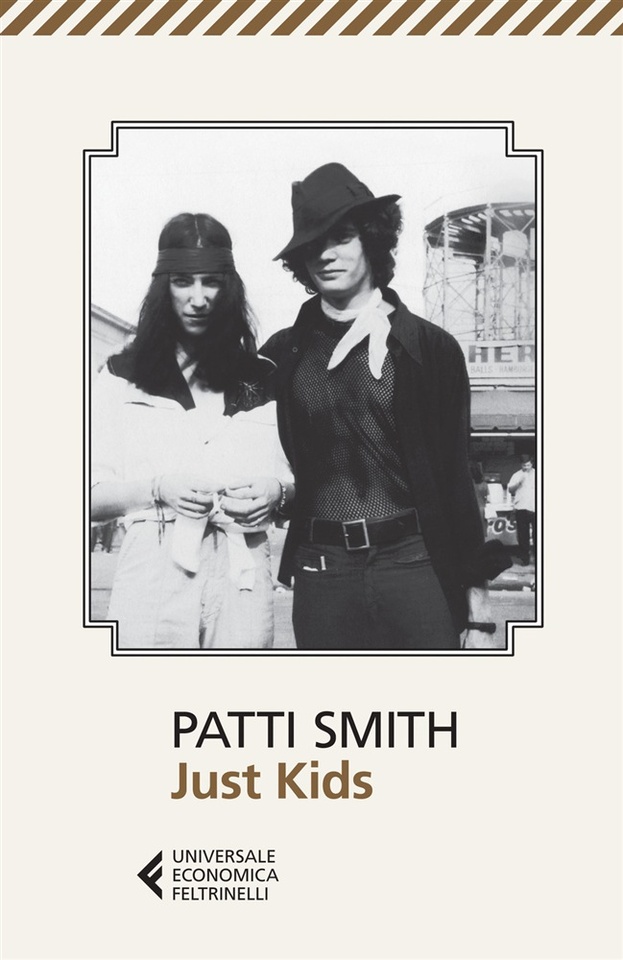le sue fondamenta avevano cominciato a cedere. Così si era prodotta nell’edificio un’inclinazione verso ovest, bizzarra e fastidiosamente vistosa, e nelle giovani donne della città, le cui energiche questue avevano sostentato il museo, una sconfinata vergogna e la tendenza a incolparsi a vicenda. Al tempo stesso, il cedimento aveva divertito non poco il personale, le cui diverse attività erano state alterate dalla decisa pendenza assunta dai pavimenti. Il responsabile del dinosauro, in effetti, aveva descritto con molto spirito la disposizione quasi fetale assunta dalle auguste ossa a lui affidate; e il numismatico, i cui esemplari mostravano la tendenza a scivolare battendo gli uni contro gli altri, fu sentito proferire commenti – fino alla noia – sugli armoniosi accostamenti venutisi così a creare. Il naturalista che si occupava degli uccelli impagliati e l’astronomo, le cui vite potevano quasi prescindere dall’equilibrio terreno, non risentirono in alcun modo del cedimento, se si eccettua la necessità di procedere come imboccando una curva inclinata per bilanciare il pavimento sghembo; camminare era, in ogni caso, un’attività poco familiare a entrambi, giacché l’uno si interessava solo al volo e l’altro a ruotare pago di sé delle sfere. Il dottissimo professore di archeologia, percorrendo distratto i corridoi obliqui, era stato visto mentre contemplava speranzoso le disgregate fondamenta. L’ingegnere e l’architetto, insieme alle stizzite cittadine, tentarono di dare la colpa in primo luogo alla scarsa qualità dei materiali utilizzati per la costruzione, in secondo luogo al peso eccezionale di alcune antichità ospitate all’interno; sul quotidiano locale un editoriale criticò la direzione del museo, la quale aveva consentito che le raccolte di meteoriti e minerali e un intero arsenale della Guerra Civile, disseppellito appena fuori città e comprendente due cannoni, venissero collocati nella parte occidentale dell’edificio; l’articolo sottolineava in tono asciutto che, se quell’ala avesse accolto invece l’esposizione di firme celebri e quella di abiti storici, forse le fondamenta non avrebbero ceduto o, quanto meno, non mentre i benefattori del museo erano ancora in vita. Poiché il quotidiano – contingente e non durevole – non era ammesso al di sotto del terzo piano, ovvero quello degli uffici, i cannoni e il resto poterono conservare la loro maldestra collocazione in barba agli editoriali, benché gli impiegati del terzo piano continuassero a leggere tutti i giorni le vignette e scorressero la prima pagina sperando di scoprirci le modalità della propria morte. La gente del terzo piano era portata alla riflessione, e credeva quasi a tutto quello che leggeva. In ciò, naturalmente, differiva poco o punto dagli eruditi residenti del primo e del secondo piano, i quali vivevano fra le vestigia imperiture del passato e facevano argute battutine sulla disintegrazione.
Elizabeth Richmond occupava un cantuccio in uno degli uffici; quella era la sezione del museo più vicina, per così dire alla superficie, dove la corrispondenza col vasto mondo esterno veniva condotta liberamente, e dove meno trovavano protezione i tipi studiosi e tremebondi. Seduta alla sua scrivania lì all’ultimo piano, nell’angolo più occidentale, giorno dopo giorno Elizabeth rispondeva alle lettere che offrivano al museo raccolte di fiori pressati o vetusti bauli da marinaio riportati dal Catai. Non è dimostrato che il suo equilibrio personale venisse alterato dalla pendenza del pavimento, né si poté dimostrare che fosse stata lei a svellere il palazzo dalle fondamenta; è innegabile tuttavia che l’uno e l’altro cominciarono a smottare all’incirca nello stesso periodo.
Shirley Jackson, Lizzie, 1954, ed. Adelphi 2014