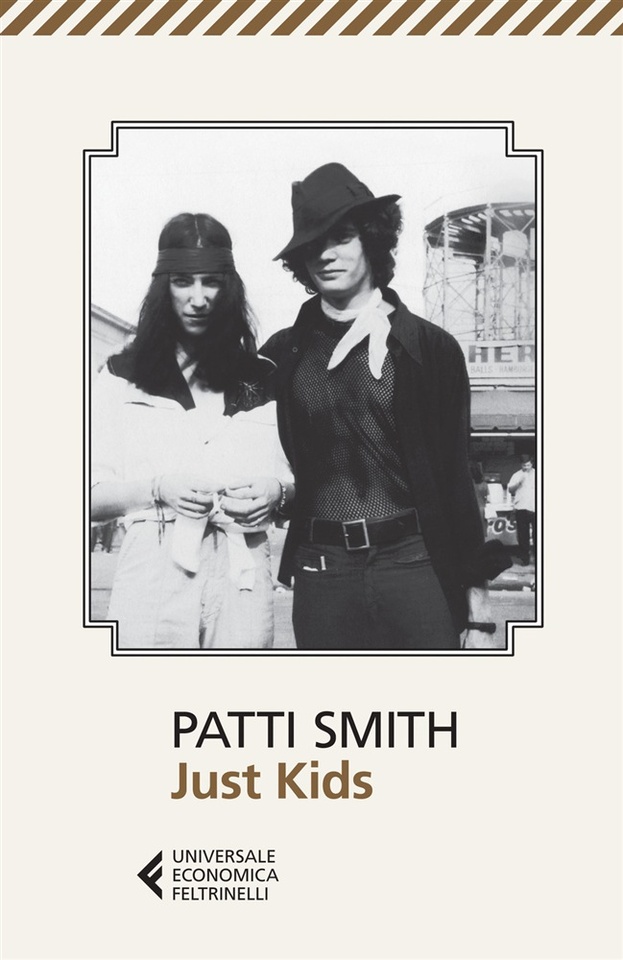Oggi sono terribilmente in ritardo col post causa ulteriore round dell’incontro me vs tumblr che si protrae ormai da tre giorni. E per la cronaca non ne sono ancora venuta del tutto a capo.
Comunque, dando per assodata la fondamentale imperscrutabilità della Tecnologia e la sua intrinseca ostilità nei miei confronti e tenendo presente che, quando c’è qualcosa che non riesco a risolvere, mi si pianta un chiodo fisso nel cervello per cui l’argomento tende a riaffiorare in modo reiterato, costante e possibilmente a sproposito, ecco, possiamo passare al post.
In realtà su quest’ennesima accoppiata libro film sono rimasta indecisa fino all’ultimo per diversi motivi, primo fra tutti il fatto che siano entrambi totalmente italiani e poi il fatto che l’italiano in questione, nel caso del film, sia Silvio Muccino. Perché, diciamocelo, quali sono le prime tre parole che ci vengono in mente al sentirlo nominare? Fratello (del regista Gabriele), paraculo (in quanto fratello del regista Gabriele) e teenager (possibilmente ululanti perché Silvio è il fratello figo del regista Gabriele – e su quest’ultima, please, non chiedetemi perché). Tant’è che l’ho sempre piuttosto snobbato – considerato anche il fatto che non sono una grande fan neanche di Gabriele Muccino (tolta La ricerca della felicità). Poi non lo so. A dicembre del 2010 ho visto il trailer di Un altro mondo e – sicuramente anche per colpa di Secret Garden di Bruce Springsteen – ho pensato che si poteva fare un tentativo (anche visto che sembrava qualcosa di ben diverso da quell’onanistica autocelebrazione immeritatamente considerata che era stato Parlami d’Amore – all’epoca non l’avevo ancora visto ma date le mie manie di indagare a ritroso su autori o registi ora il mio giudizio è espresso con cognizione di causa).
Autrice del libro è Carla Vangelista – adattatrice per il doppiaggio dei dialoghi di film come Il Pianista, The Hours, Magnolia, The Others. E’ autrice anche della sceneggiatura, cosa che ha reso la trasposizione ovviamente fedelissima e assolutamente azzeccata per quel che riguarda i tagli e le (poche) modifiche.
La trama (dalla quarta di copertina): “Andrea vive insieme a Livia una esistenza smemorata, molle, remissiva, in mezzo ad amici che, come lui, più di lui, ricamano finzioni intorno al buio del cuore, all’abisso di sentimenti inespressi. Tanti anni prima il padre di Andrea ha abbandonato la famiglia e si è trasferito in Kenya, lasciando dietro di sé solo silenzio. E ora arriva una sua lettera: vorrebbe rivedere il figlio prima di cedere alla morte.
Andrea è più rancorosamente curioso che animato da pietà filiale, ma ci va. Va in Africa. E là scopre di avere un fratello, più orfano di lui. Il padre ha lasciato a entrambi una eredità difficile. Comincia a quel punto un viaggio che è una vera e propria avventura dentro l’immensità e la maestà di un continente derelitto, e dentro la devastata interiorità di un giovane uomo che al fratello-figlio, al piccolo Charlie, deve aprire uno spazio o lasciarlo fuori da sé per sempre, nero e bastardo. In fondo, a una decina di ore di volo c’è il suo mondo che lo aspetta e dove tutto può ricominciare – come prima, come sempre. E se invece fosse possibile un altro mondo? Se sulla scacchiera dell’esistenza ci si potesse muovere senza l’ingombro di fantasmi, finalmente pieni di vento e di memoria? […]”
Il libro è scorrevole, moderatamente introspettivo, forse un po’ più crudele della sua versione cinematografica ma si mantiene comunque in equilibrio senza eccessi di sentimentalismi o intellettualismi né in un senso né nell’altro.
Anche sul film il mio giudizio è complessivamente positivo. Purtroppo anche qui mi trovo a dover fare una distinzione che, mi rendo conto, si ripresenta puntualmente per i film italiani, tra cast tecnico e cast artistico. Tecnicamente è davvero di ottimo livello: ci sono diverse sequenze – in particolare quella iniziale con la scelta (perfetta) della voce fuori campo (che poi ritorna sul finale) per riassumere i punti salienti di alcune situazioni che altrimenti avrebbero appesantito la narrazione, o la giornata passata insieme di Andrea e Charlie, o, ancora, tutta quella dedicata all’evoluzione della gestione dei nuovi ritmi di vita – che non sembrano neanche appartenere a un film italiano, anche se so che dicendo questo probabilmente mi attirerò le ire di qualcuno (mi riferisco ovviamente alla produzione italiana più recente non a tutto il cinema italiano dagli albori). Volendo dare un voto, regia, montaggio, colonna sonora (ok, sì, Secret Garden era di Jerry Maguire ma ci sta comunque bene), costumi e, come dicevo prima, sceneggiatura si meritano ampiamente un 8.5. Sul cast artistico dobbiamo calare un po’. Se ci limitiamo ai tre interpreti principali siamo ancora su un buon livello: Silvio Muccino ha definitivamente corretto i suoi difetti di pronuncia e ha imparato a parlare senza mangiarsi le parole; potrebbe ancora togliersi l’accento de roma ma finché continua ad interpretare personaggi bene o male costruiti per (e diretti da) lui la cosa non è poi così drammatica. La sua recitazione in generale è migliorata parecchio e – cosa che mi ha stupito – rende particolarmente bene nelle scene a due con Charlie dove non fa tanto l’uomo ma lascia emergere quella parte del suo personaggio che è fondamentalmente uguale a Charlie cioè quella del bambino abbandonato. Isabella Ragonese è forse un po’ troppo teatrale e scolastica soprattutto nelle scene di maggior pathos ma è comunque brava e poi non mi rallegrerò mai abbastanza di vedere un’attrice italiana che riesce a litigare senza fare l’isterica saltellante. Michael Rainey Junior è un po’ il centro e la mascotte di tutto il film. E’ bravo di quella bravura tipica dei bambini che si trovano a proprio agio a recitare, con quella componente di spontaneità che arricchisce e completa il personaggio.
Poi però arrivano le note dolenti. Perché Greta Scacchi? E soprattutto perché parla così (che sembra il doppiatore del leone di Narnia)? Non si può né sentire né vedere. Idem dicasi per Flavio Parenti che è un altro che palesemente bazzica da quelle parti per il suo cognome ma non ha nessuna dote naturale che gli permetta di far fruttare in qualche modo la fortuna che gli è capitata.
Fortunatamente hanno entrambi ruoli, se non proprio marginali, quanto meno non così invasivi da rovinare il film, che resta comunque valido.
Cinematografo.
Read Full Post »